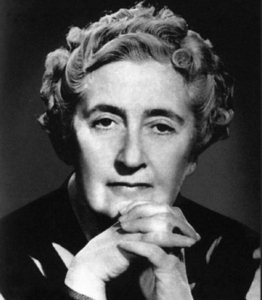Alla fine degli anni Settanta, mentre New York era attraversata da luci al neon, crisi economica e rivoluzioni culturali, sul piccolo schermo americano stava per nascere qualcosa di unico. Il 3 novembre 1978, sulla NBC, andava in onda la prima puntata di Diff’rent Strokes, arrivato in Italia qualche anno dopo prima con il titolo Harlem contro Manhattan, sostituito poi dal più affettuoso Il mio amico Arnold. Un titolo semplice per una serie che avrebbe mescolato con grazia e coraggio due elementi apparentemente distanti: la comicità e le grandi questioni sociali.
La premessa era tanto brillante quanto densa di significato: due fratellini afroamericani, Arnold e Willis Jackson, cresciuti in una casa popolare di Harlem, vengono adottati da Philip Drummond, un ricco uomo d’affari bianco che vive in un attico nell’Upper East Side di Manhattan. Da quel momento, l’incontro fra due mondi così lontani – Harlem e Manhattan, povertà e privilegio – diventa il cuore pulsante della sitcom. Ma invece di scivolare nel pietismo o nel melodramma, Il mio amico Arnold sceglie la strada della tenerezza, della risata intelligente, del confronto umano.
E in mezzo a tutto questo c’era lui: Gary Coleman, il piccolo prodigio. Dietro quel viso da eterno bambino, c’era una storia difficile. Coleman soffriva di una rara nefropatia congenita, che ne aveva compromesso la crescita. Ma davanti alla telecamera diventava un gigante. Il suo sguardo furbo, il tempismo comico perfetto e quella frase diventata un tormentone, “Che cavolo stai dicendo, Willis?”, conquistarono il mondo. Nel 1980, Coleman era l’attore televisivo più pagato d’America tra i minorenni. Una popolarità travolgente, ma che avrebbe avuto un prezzo altissimo.
La serie non era solo una macchina da risate. Episodio dopo episodio, Il mio amico Arnold affrontava temi inediti per una sitcom familiare. Si parlava di razzismo, droga, alcolismo, abusi sui minori, differenze di classe e adozione. La puntata più discussa fu senza dubbio “The Bicycle Man” (1983), in cui Arnold e un suo amico si trovano coinvolti in una situazione potenzialmente pericolosa con un molestatore. Un episodio durissimo per l’epoca, ma raccontato con tatto e responsabilità, tanto da ricevere premi e diventare materiale di studio nelle scuole.
Anche la realtà si mescolava alla fiction: Il mio amico Arnold ospitò persino la First Lady Nancy Reagan, che apparve in un episodio del 1983 per lanciare la sua campagna antidroga “Just Say No”, riconoscendo così alla serie un ruolo di rilievo nella formazione dei più giovani.
E poi c’era la colonna sonora: la sigla, It Takes Diff’rent Strokes, scritta e cantata da Alan Thicke (che anni dopo avrebbe interpretato il papà in Genitori in blue jeans), diventò una delle più iconiche della TV. Bastavano le prime note per entrare in casa Jackson-Drummond e sentirsi parte di quella famiglia improbabile ma profondamente autentica.
Il personaggio della governante, la signora Garrett, interpretata da Charlotte Rae, era così amato che ottenne uno spin-off di successo: The Facts of Life (L’albero delle mele), a sua volta diventato simbolo di girl power e educazione affettiva per tutta una generazione.
Ma come spesso accade nelle favole televisive, dietro la luce del set si nascondevano ombre lunghe. Dopo otto stagioni, la serie venne cancellata nel 1986, lasciando il pubblico senza un vero finale. E la vita dei protagonisti, fuori dal set, divenne un dramma a cielo aperto.
Gary Coleman lottò per tutta la vita contro problemi economici, legali e di salute. In uno scontro doloroso con i suoi genitori adottivi per la gestione dei suoi guadagni, perse tutto. Morì nel 2010, a soli 42 anni. Dana Plato, che interpretava la sorella Kimberly, affrontò un’esistenza tormentata da dipendenze e difficoltà finanziarie: si spense per overdose nel 1999. Solo Todd Bridges, che dava il volto al fratello maggiore Willis, è riuscito a uscire dal buio, disintossicarsi e raccontare la sua storia di rinascita in un’autobiografia che ancora oggi fa riflettere.
Un aspetto meno noto della storia della serie riguarda le minacce ricevute da Conrad Bain, l’attore che interpretava Philip Drummond. Dopo la messa in onda dello show, Bain ricevette lettere minatorie dal Ku Klux Klan, sigillate con cera da un Grand Dragon, a causa della trama che vedeva un uomo bianco adottare due bambini afroamericani. Anche Todd Bridges riferì di essere stato molestato da individui che si identificavano come membri del Klan.
Eppure, nonostante tutto, Il mio amico Arnold ha lasciato un segno indelebile. Non solo come sit-com d’intrattenimento, ma come prodotto culturale capace di educare e aprire conversazioni importanti in una società che stava imparando a guardarsi allo specchio. È stato un precursore, una pietra miliare. Ha dimostrato che si può ridere di cuore parlando anche di dolore. E che un bambino con la battuta pronta può insegnarci molto più di quanto immaginiamo.
Ascolta qui tutte le puntate del podcast:
Spotify | YouTube | Amazon Music | Apple Podcast | Rss
Immagine di pubblico dominio- fonte: Wikimedia Commons